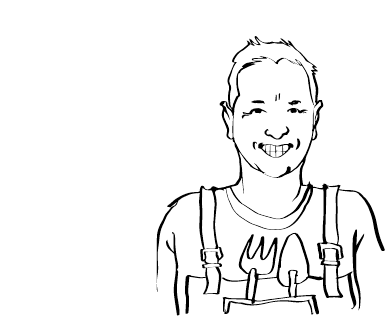Michael Kotutwa Johnson osserva il panorama e si domanda se quest’anno avrà un raccolto. È marzo, e la riserva del popolo hopi, negli altopiani dell’Arizona nordoccidentale, è un mosaico di tonalità di marrone: le montagne color bronzo sovrastano le case beige e i campi coperti di sabbia e arbusti. L’aridità regna ovunque. Venti famelici ci strappano l’umidità dalla bocca, dalla pelle e dagli occhi, lasciando al suo posto polvere granulosa.
È difficile immaginare come le piante o qualsiasi altra forma di vita possano sopravvivere in questo luogo. Eppure per millenni gli agricoltori hopi hanno coltivato mais, fagioli e zucche, sfamando le famiglie e sostenendo le loro comunità .
La cultura hopi è una delle più antiche tra quelle ancora esistenti. Questa tribù di nativi americani oggi vive in una riserva di seicentomila ettari, una piccola parte delle sue terre ancestrali. Risiedono soprattutto in villaggi costruiti in cima ad altopiani aridi, su cui cadono meno di 25 centimetri di pioggia all’anno. Ma hanno imparato a far fruttare anche questo ambiente spietato.
“La nostra agricoltura è una testimonianza della nostra fede”, spiega Johnson. Secondo la tradizione, quando gli hopi sono apparsi in questo mondo hanno incontrato Màasaw, il guardiano della Terra, che gli ha regalato una zucca piena d’acqua, un bastone appuntito e dei semi di mais, ovvero tutto ciò di cui avevano bisogno per coltivare. Ma Màasaw ha aggiunto che per sopravvivere gli hopi avrebbero avuto bisogno di un altro ingrediente essenziale: la fede in tutto ciò che facevano.
Per secoli gli hopi hanno resistito alle sfide della natura e agli effetti della colonizzazione, proteggendo le loro tradizioni e il loro territorio. Tuttavia negli ultimi decenni molti hanno smesso di coltivare, con effetti devastanti sulla salute della tribù. Nei primi anni duemila un’alta percentuale di hopi soffriva di obesità, e quasi un quinto era affetto da pressione alta o diabete, come ha confermato uno studio della Natwani coalition, che si occupa della protezione delle tradizioni agricole hopi. Oggi, invece di coltivare i prodotti che mangiano, molti hopi fanno due ore di macchina per raggiungere un supermercato fuori dalla riserva, spendendo molti soldi in benzina e generi alimentari.
Le ragioni della crisi dell’agricoltura hopi sono diverse, dalla mancanza di sostegno finanziario alle frequenti siccità dovute al cambiamento climatico. Ma Johnson vuole aiutare il suo popolo a riconquistare la sovranità alimentare e la salute. È una missione che spesso lo ha costretto ad allontanarsi dalla sua terra per lunghi periodi di tempo, spingendolo a confrontarsi con altri ambiti, dalla scienza alla politica fino all’assistenza sociale. Per Johnson è solo un altro modo per raccogliere la sfida di Màasaw. “Siamo una società basata sulla fede”, spiega. “Tutto ciò che facciamo dev’essere sostenuto dalla fede”.
Quando un bambino hopi viene al mondo, i parenti gli mettono accanto una pannocchia di mais bianco. Due settimane dopo, una zia paterna gli mette in bocca un po’ di pudding di mais dolce e lo alza verso il sole. “È per ricordargli da dove viene e iniziarlo alle nostre usanze”, spiega Johnson.
Per gli hopi queste “usanze” – la cultura, lo stile di vita, la religione e la filosofia – sono legate all’agricoltura e all’amore per la terra. Non c’è alcuna separazione tra il sistema agricolo e la spiritualità.
I ragazzi sono coinvolti nell’agricoltura fin dalla tenera età. Johnson ha cominciato a lavorare nei campi a otto anni. Era estate e i suoi genitori, che vivevano fuori dalla riserva, lo avevano affidato al nonno nella fattoria di famiglia. Quando Johnson si lamentò del fatto che non c’era la tv, suo nonno trovò subito la soluzione. Il giorno dopo svegliò Johnson alle 5 e mezza del mattino. “Abbiamo zappato e riparato le staccionate per tutto il giorno. Non mi sono mai più lagnato”, racconta.
Così come il mais emerge dopo settimane passate nell’oscurità, Johnson si sentiva rivitalizzato dal sole e dall’aria aperta
Presto Johnson cominciò ad apprezzare il lavoro nei campi. Passò tutte le estati successive ad aiutare il nonno e alla fine s’iscrisse alla Cornell university di Ithaca, nello stato di New York, per studiare l’agricoltura convenzionale. Lì capì quanto fosse speciale l’eredità dei suoi antenati.
Un giorno Johnson sentì un professore spiegare che il mais ha bisogno di almeno ottanta centimetri di pioggia all’anno per crescere. Dato che aveva già ottenuto molti raccolti senza nessuna irrigazione in un luogo in cui le precipitazioni non superavano i 25 centimetri, Johnson si mise a ridere. Ma quell’episodio lo avrebbe fatto anche riflettere. “Cosa facevano di diverso gli hopi? E cosa si poteva imparare dalla loro tradizione?”.
Ogni primavera, quando la neve invernale è sciolta da tempo, per gli hopi comincia la stagione della semina. Eliminano pazientemente le erbacce, spazzano via la sabbia e scavano delle buche con dei bastoni appuntiti. Secondo l’agricoltura convenzionale il mais dev’essere seminato a 2,5 centimetri di profondità, ma gli hopi scavano dai 15 ai 45 centimetri per raggiungere la terra più umida. In ogni buco depositano tra i dieci e i venti semi di mais, si spostano di tre passi e ripetono il procedimento.
Per duemila anni gli antenati di Johnson sperimentarono tecniche per approfittare della neve invernale e della pioggia estiva, cercando di proteggere il raccolto dai venti, dagli insetti e dai corvi. Gli hopi hanno imparato che è meglio seminare in aree vicine ai letti asciutti dei corsi d’acqua o nelle pianure alluvionali, dove alcune erbacce indicano la presenza di umidità sotto la superficie. Dopo secoli di prove ed errori, hanno imparato a osservare gli animali per determinare l’umidità del suolo, la profondità dello scavo e la distanza tra le buche.
Quando le piantine di mais spuntano, l’agricoltore elimina quelle più corte, lasciando solo le più robuste. In questo modo sono stati selezionati i semi più forti e resistenti alle siccità.
Per prendersi cura del raccolto servono attenzione quotidiana e un rapporto intimo con le piante. D’estate Johnson cammina tra i campi, parlando e cantando al mais, incoraggiandolo a crescere forte. Ispeziona ogni pianta con gentilezza alla ricerca d’insetti, e quando li trova li schiaccia uno per uno tra le dita. Gli hopi non usano fertilizzanti né insetticidi. “La nostra soluzione è la natura, non i prodotti chimici”, spiega. “Viviamo in questo ambiente e non abbiamo intenzione di manipolarlo o sfruttarlo”.
Da quando preleva il seme dal magazzino al raccolto tocca il mais sette o otto volte. È questa attenzione alla terra che ha permesso agli hopi di sopravvivere, spiega Johnson.
Le usanze agricole dei nativi americani variano molto a seconda dei luoghi, ma i princìpi di responsabilità e protezione della natura sono comuni a tutte le tribù, spiega Toni Stanger-McLaughlin, residente nella riserva delle tribù confederate di Colville e amministratore delegato del Native american agriculture fund. “Nelle nostre storie sulla creazione, un tema comune è quello degli animali e delle piante che si consegnano alle persone in modo rispettoso”, spiega Stanger-McLaughlin. “In cambio noi ci prendiamo cura di loro e ne garantiamo la sopravvivenza, seguendo usanze che proteggono il loro ecosistema”.
Durante la grande depressione degli anni trenta gli hopi furono relativamente risparmiati dalla crisi, perché producevano il cibo che consumavano. Ma la pandemia di covid-19 è stata tutta un’altra storia. A causa delle restrizioni sugli spostamenti, infatti, molti hopi hanno dovuto restare in fila per ore in attesa delle distribuzioni di cibo. “La pandemia ci ha mostrato la necessità di ritrovare la sicurezza alimentare”, spiega Kyle Nutumya, direttrice della Natwani coalition.
Nel 2004 uno studio della coalizione sulle pratiche alimentari, agricole e sanitarie degli hopi ha rivelato che meno di un terzo degli intervistati coltivava la terra, in un momento in cui il costo del cibo era estremamente alto. Nella riserva ci sono pochi negozi, e chi fa parte della tribù è costretto a guidare per due ore fino a Winslow o a Flagstaff. Secondo lo studio gli hopi spendevano quasi sette milioni di dollari l’anno per portare il cibo nelle loro comunità.
La crisi dell’agricoltura tradizionale ha avuto un duro impatto sulla salute fisica e psicologica di questo popolo. Insieme alla disoccupazione, è il principale motivo dell’abuso di alcolici e stupefacenti nella riserva, spiega Johnson. “Stanno dimenticando chi sono. Cercano qualcosa che possa riempire il vuoto”.
I più grandi ostacoli all’agricoltura hopi nascono dalla mancanza di sostegno. Johnson coltiva i suoi campi da cinquant’anni e discende da una famiglia che per generazioni ha curato e protetto il suo ambiente, ma non è il proprietario della terra che lavora. Come altre tribù di nativi americani, gli hopi sono solo affidatari delle terre dove vivono, che appartengono allo stato. Da questo derivano molti ostacoli, spiega Johnson. Gli agricoltori hopi non possono prendere decisioni sulle proprie terre o adattarsi alle condizioni che cambiano senza l’autorizzazione del governo federale.
Nello studio del 2004, il mancato accesso alla terra era la causa di gran lunga più citata da chi aveva rinunciato a coltivare. Tutti gli intervistati hanno elencato la mancanza d’acqua e di accesso alle terre produttive come le principali barriere all’agricoltura.
Inoltre gli agricoltori nativi sono sempre stati esclusi dal sostegno finanziario e dai sussidi garantiti agli agricoltori convenzionali. Nel 2010 l’amministrazione Obama stanziò 760 milioni di dollari per risarcire i coltivatori nativi a cui erano stati negati i finanziamenti a tassi agevolati concessi ai loro colleghi bianchi.
Ma gli ostacoli per i coltivatori indigeni non sono finiti qui. Uno studio del 2021 ha evidenziato che gli hopi, come la maggior parte delle tribù native, non ricevevano i finanziamenti per i servizi ambientali usati in tutto il mondo per favorire la conservazione della biodiversità, combattere il cambiamento climatico e sostenere lo sviluppo economico.
La casa tradizionale di Johnson nella riserva hopi
(Jane Palmer, Al Jazeera)
Gli autori dello studio hanno concluso che l’ordinamento fondiario – che stabilisce chi “controlla” o vanta diritti sulla terra – è il problema principale per le comunità indigene che vogliono accedere a questi programmi. Quando le agenzie governative vogliono collaborare con le tribù, devono firmare un accordo scritto con i nativi, che spesso controllano la terra come collettivo e devono dimostrare di esserne proprietari.
Dato che ogni componente ha dei diritti sulla terra, ogni accordo richiede un gran numero di firme. Questo provoca inevitabilmente lunghi ritardi. Le agenzie sono costruite per avere rapporti con singoli proprietari. “In questo caso il modello non funziona”, spiega Johnson.
Alcuni ostacoli sono di natura burocratica: secondo Johnson la mole di documenti e lavoro necessaria a far approvare i piani di gestione delle risorse agricole (il tutto senza assistenza tecnica) è proibitiva. Un problema altrettanto grave è il fatto che i politici, le autorità e gli scienziati non riconoscono il valore delle conoscenze agricole indigene.
“Loro sono qui da molto prima di noi, e coltivano nel deserto da secoli”, spiega Trent Teegerstrom, specialista in economia agricola e delle risorse all’università dell’Arizona. “Non dare il giusto valore alle loro usanze è molto grave”.
Gli hopi credono di essere come il mais, e Johnson dice di aver percepito quella somiglianza quando tornò nella riserva dopo aver finito gli studi. Così come il mais emerge in un nuovo mondo dopo settimane passate nell’oscurità, Johnson si sentiva rivitalizzato dal sole e dall’aria aperta dopo gli anni vissuti in città. La routine del lavoro nei campi gli diede il tempo di pensare al suo futuro.
“Man mano che invecchio aumenta il mio amore per la terra, aumentano le mie conoscenze e aumenta la convinzione di avere la responsabilità di aiutare le persone”, spiega. Dato che non aveva figli, Johnson capì di dover sostenere il suo popolo, e lo fece attraverso l’agricoltura, sedendosi ai tavoli dove si prendono le decisioni politiche e iscrivendosi a un dottorato in gestione delle risorse naturali all’università di Tucson, a sette ore di auto di distanza.
“Dovevo imparare a parlare in una nuova lingua, in modo che le persone dall’altro lato della staccionata potessero capire da dove venivo”, ricorda Johnson. “Allo stesso tempo potevo cogliere alcuni aspetti positivi della scienza e portarli a casa con me”. La sua ricerca si concentrò sulle barriere che impediscono agli agricoltori indigeni di partecipare ai programmi federali per la conservazione dell’ambiente e sul modo di cancellarle.
Johnson ha applicato allo studio la stessa determinazione che ha imparato coltivando la terra. Ci ha messo dodici anni a concludere il dottorato mentre continuava a lavorare i suoi campi. L’interesse suscitato dalla sua campagna per i diritti degli hopi è stato tale che quando ha discusso la tesi, nel 2019, la sala era gremita. Johnson ha descritto i secoli di esperienze raccolte dagli hopi e ha mostrato le pannocchie del caratteristico mais bluastro coltivato dal suo popolo, invitando gli ascoltatori a portare a casa i semi per piantarli.
Fuori dalla riserva la missione di Johnson è far conoscere la sapienza agricola dei nativi e far capire che le loro tecniche tradizionali possono contribuire a proteggere la terra e la biodiversità, adattandosi alle fluttuazioni ambientali. Spesso Johnson cita la statistica secondo cui i popoli indigeni – circa il 5 per cento della popolazione mondiale – proteggono l’80 per cento della biodiversità globale sul 25 per cento delle terre. I suoi appelli puntano a sostenere e rafforzare pratiche già esistenti, non a reinventare la ruota.
◆ Anni sessanta Nasce a Kykotsmovi, in Arizona.
◆ 1999 Si laurea in scienze agricole alla Cornell university di Ithaca e torna a lavorare le terre di famiglia nella riserva hopi.
◆ 2019 Completa il dottorato in gestione delle risorse naturali.
◆ 2022 Ottiene un incarico all’Indigenous resilience center di Tucson, in Arizona.
“La conservazione è un tema che può attirare l’attenzione sul nostro modo di gestire la terra”, spiega Johnson. “Spiegare alla comunità ambientalista quello che stiamo facendo ci darà più forza politica per ottenere cambiamenti”.
Riconoscere e imparare dalla tradizione indigena è molto importante per adattarsi al cambiamento climatico, spiega Johnson. I nativi americani hanno secoli se non millenni di esperienza nell’adattamento a un ambiente che cambia, e hanno sviluppato sistemi flessibili e resilienti per coltivare e conservare i prodotti di cui si nutrono.
Gli hopi hanno l’abitudine di coltivare abbastanza da sfamarsi per diversi anni, creando una riserva per i momenti difficili. Anche se un’annata sembra troppo secca per coltivare, Johnson pianta comunque alcune varietà di mais. “Altrimenti le piante non si adattano, non cambiano. Quei piccoli semi sanno come fare, mentre noi esseri umani lo abbiamo dimenticato”.
La necessità di adattarsi al cambiamento climatico è un altro dei motivi per cui gli hopi dovrebbero continuare a coltivare la terra a prescindere dalle circostanze, spiega Johnson. In questo modo si possono mettere da parte risorse fondamentali e permettere alle piante di adattarsi al clima sempre più caldo e secco. “Dobbiamo avere fede e continuare a coltivare. Non possiamo arrenderci. Siamo agricoltori”.
Johnson spera che i suoi sforzi al di fuori della riserva abbiano un effetto benefico anche al suo interno. Vorrebbe creare nuovi programmi di sostegno per riavvicinare all’agricoltura il maggior numero possibile di hopi, dando vita a un’economia autosufficiente che possa aiutare la tribù dal punto di vista finanziario e creare nuovi posti di lavoro. “I nativi devono avere piena sovranità alimentare. Quindi dobbiamo essere noi a guidare questo processo”.
Johnson non aveva mai pensato che un giorno avrebbe ottenuto un dottorato o si sarebbe occupato di politica, ma ora il suo obiettivo a lungo termine è usare la sua formazione scientifica e politica e le sue esperienze come coltivatore per aiutare i nativi americani a sviluppare la loro agricoltura e a rafforzare l’indipendenza, la salute e il senso di identità che ne derivano. “L’agricoltura indigena realizza il vero potenziale dell’ambiente e ci restituisce doni meravigliosi”, dice Johnson. “Il mio ruolo è mostrare che possiamo ancora seguire questa strada”.
Al Tribal nations summit del 2021, la Casa Bianca ha garantito il suo impegno a incorporare le conoscenze tradizionali indigene nel percorso scientifico, sociale ed economico degli Stati Uniti. In seguito si sono aggiunti molti altri progetti per includere i nativi americani e la loro cultura nelle decisioni politiche.
“È un ottimo inizio, ma ora comincia il vero lavoro”, sottolinea Johnson. Ci sono nuove sfide per integrare la conoscenza agricola indigena nei programmi federali, dalla tutela delle tradizioni al loro adattamento per renderle utili anche per gli agricoltori non indigeni.
Ora che la politica ha finalmente riconosciuto il valore delle conoscenze indigene, Johnson si sta impegnando perché i nuovi progetti favoriscano le popolazioni native. Per questo ha appena ottenuto un nuovo incarico all’Indigenous resilience center di Tucson.
Johnson ha trovato il suo posto in una specie di “fattoria” accademica, dove può piantare semi, nutrire relazioni e usare la conoscenza tradizionale insieme alla scienza occidentale per contribuire allo sviluppo dell’agricoltura indigena nei prossimi decenni.
Come i suoi antenati prima di lui, usa l’ingegno per trovare nuove soluzioni, soprattutto rispetto al cambiamento climatico. “Non dovremmo cercare di terrorizzare le persone per convincerle a cambiare, o sfruttare le loro paure”, spiega. “Dobbiamo dargli speranza”.
Nei prossimi mesi Johnson pianterà e si prenderà cura del mais, dei fagioli e dei meloni in vista del prossimo raccolto.
Osservando il panorama brullo, nella sua mente vede già i campi coperti dalle foglie verdi di giovani piante di mais che si protendono verso il sole. “Quando vedi la prima pianta è sempre molto emozionante. È come un bambino appena nato che emerge dal suolo”.
Ma per ora tutto ciò che ha è la sua fede. Sposta con il piede uno strato di sabbia. Il suo cane Soya continua l’opera. A meno di tre centimetri di profondità il terreno è più scuro a causa dell’umidità. Soya scava ancora più in profondità e il terreno diventa color rame. Johnson sorride. Sarà una buona annata. ◆ as